|
“Soffiando, inalando, espirando ed aspirando, espellono il
vecchio per assorbire il nuovo. Si scrollano come gli orsi e si stirano come gli
uccelli. Fanno ciò per prolungare la vita, sono gli adepti del Daoyin, gente che
nutre la propria forma emulando Peng il vegliardo”
Zhuagzhi
“È immorale ciò che non fa crescere la conoscenza”
Spinoza
Sotto il nome Daoyin (o Doyin) si raggruppano i gli esercizi
tradizionali (con le pratiche di automassaggio ad essi abbinate), i cui
movimenti vengono eseguiti per lo più in posizione seduta, salvo alcune
eccezioni, e consistono soprattutto di allungamenti muscolari ed aperture
articolari. Qualcuno potrebbe affermare che gli esercizi Daoyin fossero una
sorta di stretching ante-litteram. Per taluni esercizi, questo è
anche vero, ma quello che li distingue è comunque l’approccio di profonda
coscienza al movimento, i presupposti completamente differenti ed infine il
cammino che, a partire da questi, si può intraprendere.
Per la teoria della Medicina Cinese, ogni muscolo contratto ed ogni
articolazione “chiusa” è un enorme impedimento al flusso di Qì e Xue (sangue)1.
Il loro scopo principale è quello di attivare la circolazione energetica e
rimuovere le eventuali ostruzioni alla libera circolazione del Soffio che
possono essere causate da molti fattori, come una malattia, un disturbo
emozionale od errori dietetici. Maspero ci ricorda che il Maestro Ning sosteneva
che «la Guida del Soffio, xingqì, regola l’interno, e la Ginnastica, daoyin,
regola l’esterno», evidenziando così l’importanza relativa delle due
tecniche. Vediamo quindi crearsi una relativa opposizione Yin-Yang:
interno-esterno o ancora, come indicato più sopra, Neigong-Waigong. Per tale
motivo gli esercizi di Guida del Soffio (Qìgong) e quelli di Dao Yin, possono
essere considerati complementari.

Secondo la tradizione taoista questi esercizi, da adattare alle stagioni,
vanno eseguiti immediatamente prima o durante il levare del sole. Probabilmente
gli esercizi più antichi, in Cina, sono le danze sciamaniche che imitano il
movimento degli animali. Durante la dinastia Zhou (1028 – 221 a.C.) c’era un
rituale popolare per il Capodanno conosciuto come "Il grande Esorcismo" (Da No).
Uno sciamano indossava una pelle d’orso sulla testa, con quattro occhi d’oro,
come per guardare nelle quattro direzioni. Danzando attraverso il villaggio,
seguito da una processione di abitanti che indossavano maschere rappresentanti
gli animali dello zodiaco (dragone, tigre, cavallo, …), lui cacciava via le
pestilenze e i demoni. Simili danze degli animali sono registrate su pannelli di
arte rupestre ovunque in Cina. Alcune di queste comprendono uniformi, sequenze
di danze prestabilite eseguite da molte persone insieme. Altre raffigurano
combinazioni di posture di animali ed esercitazioni militari, dando delle
possibili evidenze di un antico legame tra movimenti degli animali, Qigong e
arti marziali. Ogni movimento agisce in modo specifico sulle “sei energie”, ha
un particolare “tropismo” sulle diverse “orbis (movimenti)” o sui differenti
distretti del corpo ed infine tratta e prevene una serie di patologie.
Nel
1973, gli archeologi, vicino la città di Changsha, la capitale della provincia
dello Hunan, hanno trovato un reperto che è diventato il grande locus di
informazioni sul Qigong antico. Quando hanno scavato la tomba del re Ma (ca. 168
a.C.), in una delle bare hanno trovato un pezzo di seta arrotolato, mezzo
coperto dall’acqua. Alto circa 50 cm e lungo 100, il reperto in seta contiene i
più antichi disegni di posizioni daoyin, quattro file orizzontali di undici
figure ognuna, in tutto 44. L’intera mappa era chiamata "Daoyin tu" (lett. La
mappa del daoyin). Le figure dipinte rappresentano quasi tutte le categorie del
Qigong moderno: respirazioni, posizioni stanti, movimenti, e auto – massaggio da
in piedi, seduto e sdraiato. Molte delle figure si flettono, si stirano, o
ruotano. Con questa scoperta è stato possibile, non solo leggere dell’antico
daoyin, ma vedere realmente cosa fosse la pratica. Ci sono didascalie a fianco
alla maggior parte delle figure sulla mappa. Alcune delle didascalie sono nomi
di animali, tra cui: il falco, il lupo, la gru, il dragone, il gatto, l’orso;
forse questi erano i nomi dei movimenti. Altre didascalie descrivono come
muovere il corpo: "flettersi alla vita, ondeggiare le braccia," ecc. Molto
interessanti sono le didascalie che descrivono le disfunzioni, come malattie di
reni, flatulenza, ginocchia doloranti, lombaggine, reumatismi, disturbi
gastrici, e ansia, suggerendo che già nel 168 a.C. specifiche tecniche erano
usate per trattare specifiche malattie. Questi esercizi potrebbero essere stati
comunemente conosciuti come "rimedi caserecci" o forse prescritti da terapisti
specializzati. Le figure nella "Daoyin tu" rappresentano sia giovani sia
anziani, uomini e donne, persone comuni e burocrati.
Secondo una studiosa di Taoismo ed insegnante di Qigong, Patricia N.T. Leong,
"Il variare genere e abiti nelle figure, sembra indicare che gli esercizi
terapeutici e l’aspirazione alla longevità non erano riferite ad una classe, ma
erano interesse di un ampio spettro della società. La "Daoyin tu" è il più
raffinato esempio della consistenza e continuità delle tecniche terapeutiche del
Qigong. Per la maggior parte, gli esercizi sembrano così simili alle posture del
Qigong moderno che è possibile dedurne come fossero praticate. I ricchi temi
della "Daoyin tu" sono considerati come una tappa lungo la linea percorsa
attraverso la fabbrica della storia del Qigong e della sua evoluzione"2.
|
Il "Canone taoista", una collezione letteraria di 1120 volumi,
comprende un volume specificatamente dedicato al soggetto: il "Classico
del daoyin". Il testo fu probabilmente compilato intorno al 1145 d.C.,
quando fu menzionato per la prima volta in un riferimento bibliografico.
Gli esercizi in esso, tuttavia, risalgono alla fine del sesto secolo. I
metodi descritti coincidono notevolmente con esercizi e meditazioni di
Qigong tuttora insegnati in Cina. Anche lo scopo del Qigong è rimasto lo
stesso. Secondo il "Classico del Daoyin", l’adepto impara ad "espellere
le malattie, estendere i suoi anni e prolungarsi la vita". |
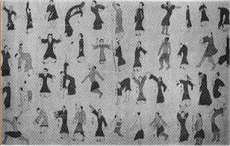 La mappa di Changsha. Il fatto che nel rotolo
fossero rappresentate anche donne in una civiltà in cui la norma
esplicita per gli storiografi fu di ignorarle, non deve stupire; prima
del 221 a.C. la maggioranza dei protomedici Wu era di sesso femminile,
ciò è attestato dall’esistenza di un altro carattere, poi caduto in
disuso, che serviva a distinguere gli Wu di sesso maschile. La mappa di Changsha. Il fatto che nel rotolo
fossero rappresentate anche donne in una civiltà in cui la norma
esplicita per gli storiografi fu di ignorarle, non deve stupire; prima
del 221 a.C. la maggioranza dei protomedici Wu era di sesso femminile,
ciò è attestato dall’esistenza di un altro carattere, poi caduto in
disuso, che serviva a distinguere gli Wu di sesso maschile. |
Anche il "Canone Taoista" contiene migliaia di visualizzazioni terapeutiche e
mistiche. Il testo del "Classico del Daoyin" è contenuto anche nell’opera
dell’undicesimo secolo, intitolata: "Yun Ji Qi Qian" ("Il sacchetto di nuvole in
sette tavole"), che comprende anche importanti commentari sulle grandi opere
della meditazione taoista. Secondo le forme arcaiche e clasiche del Daoyin
Partendo dalla respirazione, si fa circolare il Qi con l’intenzione (Yi) e lo si
conduce in tutto il corpo, stimolando cosi il funzionamento degli organi ed
attivando la circolazione del sangue e dei liquidi. Le pratiche del nei gong
permettono di trarre energia dall’ambiente e tengono presente i cicli naturali
delle stagioni e gli eventi cosmici. Questo “lavoro interno” si fonda sulla
calma interiore e tra gli altri effetti comporta la stimolazione dell’energia
sessuale e la purificazione dello spirito (Shen)3.
La tecnica più usata si
definisce Tuna-Daoyin. La tecnica di espulsione ed assorbimento (tuna ) e quella
di induzione del “soffio” (daoyin ) sono due aspetti di uno stesso fenomeno.
Tuna è la tecnica di respirazione embrionale (xiantian houxi : respirazione del
cielo anteriore) che accompagna le trasformazioni stagionali. Durante il lavoro
respiratorio, la bocca ed il naso hanno un‘azione congiunta per proteggere e
rinforzare le funzioni del cuore, del fegato, della milza, dei polmoni e dei
reni. L’induzione del “soffio” (daoyin) è la forza che spinge il “soffio” nel
campo di cinabro principale durante l’inspirazione. l’intenzione dirige il
“soffio” che, grazie ai movimenti di diversi organi, sarà spinto nei meridiani
perché circoli nell’insieme del corpo. La tecnica
 del tuna segue una divisione
stagionale del metodo respiratorio, che ha per funzione quella di calmare il
fuoco dei 5 organi (cuore, fegato, milza, polmoni e reni), e di nutrirli,
prevenendo le malattie4. Secondo i principi del Daoyin del i Canali sono in
grado di ricevere ed eliminare il Binqi (Qi negativo). Una protratta cattiva
postura fisica e ripetute emozioni negative sono responsabili dell’accumulazione
del Binqi. Quando il Binqi si accumula, esso blocca i canali e le loro
diramazioni. Questa è, in realtà, la principale causa delle malattie, per cui
consideriamo l’espulsione del Binqi come la chiave della cura della maggior
parte delle affezioni5. Gli automassaggi sono invece la parte complementare al
movimento e, naturalmente, hanno l’obiettivo di sciogliere le aree interessate,
portare il Soffio nella muscolatura, nelle articolazioni ed anche nelle zone
profonde. Nell’esecuzione delle manovre è indispensabile mantenere una postura
corretta ed in particolare va privilegiato l’allineamento della colonna
vertebrale per favorire la circolazione del Qi e il radicamento con il suolo. Le
articolazioni devono essere libere, i polsi morbidi ed il corpo rilassato in
tutte le sue parti; solo così sarà possibile utilizzare correttamente la propria
energia ed eseguire un corretto automassaggio. La condizione di rilassatezza
fisica e mentale gli garantirà una buona esecuzione. del tuna segue una divisione
stagionale del metodo respiratorio, che ha per funzione quella di calmare il
fuoco dei 5 organi (cuore, fegato, milza, polmoni e reni), e di nutrirli,
prevenendo le malattie4. Secondo i principi del Daoyin del i Canali sono in
grado di ricevere ed eliminare il Binqi (Qi negativo). Una protratta cattiva
postura fisica e ripetute emozioni negative sono responsabili dell’accumulazione
del Binqi. Quando il Binqi si accumula, esso blocca i canali e le loro
diramazioni. Questa è, in realtà, la principale causa delle malattie, per cui
consideriamo l’espulsione del Binqi come la chiave della cura della maggior
parte delle affezioni5. Gli automassaggi sono invece la parte complementare al
movimento e, naturalmente, hanno l’obiettivo di sciogliere le aree interessate,
portare il Soffio nella muscolatura, nelle articolazioni ed anche nelle zone
profonde. Nell’esecuzione delle manovre è indispensabile mantenere una postura
corretta ed in particolare va privilegiato l’allineamento della colonna
vertebrale per favorire la circolazione del Qi e il radicamento con il suolo. Le
articolazioni devono essere libere, i polsi morbidi ed il corpo rilassato in
tutte le sue parti; solo così sarà possibile utilizzare correttamente la propria
energia ed eseguire un corretto automassaggio. La condizione di rilassatezza
fisica e mentale gli garantirà una buona esecuzione.
Le posture principali da
tenere al levar del sole per alcuni minuti ogni giorno sono6:
Ma Pu, Posizione del cavaliere: I piedi sono paralleli e distanziati circa la
distanza delle spalle; il peso è distribuito su entrambi i piedi che sono
“radicati” al terreno; le ginocchia sono leggermente flesse, con la verticale
che cade sulla punta del piede, le anche sono rilassate e la schiena è eretta
perché la testa è appesa con un filo al cielo. Le spalle sono abbandonate così
anche i gomiti ed i polsi, tutto il peso è scaricato in egual misura sui piedi. Kon Pu, Posizione dell’arciere: Pur valendo in linea generale le indicazioni
della posizione precedente, in questo caso una gamba è avanti rispetto all’altra
e sorregge il 70% del peso; l’altra ha il piede leggermente ruotato verso
l’esterno
L’automassaggio e le corrette posture consentono di:
Inoltre il massaggio deve essere dolce e quindi amorevole, energico quando è
necessario per stimolare con vigore, continuo, senza brusche o improvvise
manovre che interrompono l’armonia del trattamento e profondo cioè deve lavorare
sulla struttura energetica della persona. Occorre completare il trattamento con
massaggio delle mani e dei piedi (jian an mao)7.
Lo scopo delle tecniche del Daoyin è triplice:
1. Tiao Shen - controllo del corpo
2. Tiao Xi - controllo del respiro
3. Tiao Xin - controllo del cuore mente
Vediamo cosa deve intendersi con queste definizioni8:
DEFINIZIONE |
RIPRISTINO DELLE FUNZIONI CARENTI (f. terapeutica) |
ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI LATENTI |
TIAO SHEN - controllo del corpo |
Ripristinare il corretto
equilibrio tra Yin e Yang
Coordinazione
Rilassamento, equilibrio,
armonia, retto scorrimento del Qi |
Sviluppo delle
capacità di assorbire, emettere e dirigere il Qi tanto all’interno quanto
all’esterno del proprio corpo |
TIAO XI - controllo del respiro |
Respirazione naturale lenta, sottile e profonda, emissione vocale
(si è verificato che all’emissione di un determinato suono, corrisponde
l’attivazione di certe zone) |
Respirazione embrionale, utilizzo della
respirazione per dirigere il DAN (forma condensata e potenziata della nostra
energia individuale) |
|
TIAO XIN - controllo della
mente
(il rilassamento è difficile
se non si controllano i pensieri) |
Leggerezza, rilassamento, utilizzo dell’immaginazione per indurre
rilassamento o per attivare processi di autoguarigione |
Attivazione di facoltà sensoriali fuori dell’ordinario (es.: visualizzazione del Qi),
acquisizione di capacità super-normali attraverso l’attivazione di
risorse psichiche latenti |
A cura dell’Associazione Wangqi
Note
La teoria dei “canali energetici”, elaborata nell’intento di spiegare le
modalità di circolazione del Qi nell’organismo, sembra sia nata in seguito alle
osservazioni sulla pratica del Daoyin con la quale sarebbe stato possibile
sentirne lo scorrimento del flusso.
Referenze
1 Boschi G. : Medicina Cinese : la radice e i fiori, Ed. CEA, Milano, 2004.
2 Hoizey D., Hoizey M.J. : Histoire de la médecine chinoise , Ed. Payot, Paris,
1988.
3 Guangde Z.: Daoyin yangsheng gong. Esercizi fisici e di respirazione per il
mantenimento della salute, ed. Nuova Ipsa, Palermo, 1992.
4 Rambelli R. (a cura di): Wushu. Antiche tecniche cinesi per la salute e il
benessere, Ed. Hermes, Milano, 1989.
5 Raphael N.: Mesto M. (a cura di): Il libro della medicina cinese, Ed. Hobby &
Work Italiana , 1996.
6 Brescia T.: Il tao della medicina. La scienza olistica e la medicina
tradizionale cinese, Ed. Hermes, Milano, 2001.
7 Corradin M., Di Stanislao C., Parini M. (a cura di): Medicina Cinese per lo
shiatsu ed il tuina, Voll I-II, Ed. CEA, Milano, 2001.
8 Boschi G.: Cos’è il Qi Gong in breve,
http://www.giuliaboschi.com/pubblicazioni/qigong.html#1, 1999.
|

